
Il Sidereus Nuncius di Galileo Galilei, pubblicato la prima volta a Venezia nel 1610, ha segnato un vero e proprio punto di svolta nella storia della filosofia e della scienza, sia per le provocazioni che sollevava alle antiche concezioni del cosmo, sia per l'impiego di un nuovo strumento: il telescopio.
Proviamo a rileggere e a commentare alcuni passi di questa opera. Scriveva Galileo:
E più avanti aggiungeva:
L’esistenza di quattro oggetti che orbitano attorno a Giove era la prova incontrovertibile che non tutti gli oggetti celesti girano intorno alla Terra. Se quelle lune tanto distanti orbitano intorno a Giove, ignorando la Terra, è difficile pensare che questa sia davvero il centro dell’Universo.
Il telescopio e il metodo scientifico furono le potenti armi utilizzate da Galileo per affermare la rivoluzione copernicana e abbattere la visione aristotelica del cosmo. Le sue osservazioni lo convinsero che Aristotele si sbagliava e che la ragione stava dalla parte di Copernico!
Purtroppo le sue ricerche scientifiche sconfinavano nel territorio della teologia… ma questo è un altro capitolo della storia, a cui dedicheremo un post a breve.
Proviamo a rileggere e a commentare alcuni passi di questa opera. Scriveva Galileo:
Grandi cose per verità in questo breve trattato propongo all'osservazione e alla contemplazione di quanti studiano la natura. Grandi, dico, e per l'eccellenza della materia stessa, e per la novità non mai udita nei secoli, e infine per lo strumento mediante il quale queste cose stesse si sono palesate al nostro senso.
[…] Ma quel che di gran lunga supera ogni meraviglia, e principalmente ci spinse a renderne avvertiti tutti gli astronomi e filosofi, è l'aver scoperto quattro astri erranti, da nessuno, prima di noi, conosciuti né osservati, che, a somiglianza di Venere e Mercurio intorno al Sole, hanno le loro rivoluzioni attorno a un certo astro cospicuo tra i conosciuti, ed ora lo precedono ora lo seguono, non mai allontanandosene oltre determinati limiti. E tutte queste cose furono scoperte e osservate pochi giorni or sono con l'aiuto d'un occhiale che io inventai dopo aver ricevuto l'illuminazione della grazia divina.
E più avanti aggiungeva:
[…] poiché ora seguono (i quattro astri medicei, come li chiamava lo stesso Galileo), ora precedono Giove ad uguali intervalli e si allontanano da esso solo ben poco spazio ora verso oriente ora verso occidente, e lo accompagnano sia nel moto retrogrado che nel diretto, a nessuno può nascer dubbio che compiano attorno a Giove le loro rivoluzioni, e nello stesso tempo effettuino tutti insieme con periodo dodecennale il lor giro intorno al centro del mondo.
L’esistenza di quattro oggetti che orbitano attorno a Giove era la prova incontrovertibile che non tutti gli oggetti celesti girano intorno alla Terra. Se quelle lune tanto distanti orbitano intorno a Giove, ignorando la Terra, è difficile pensare che questa sia davvero il centro dell’Universo.

Il telescopio e il metodo scientifico furono le potenti armi utilizzate da Galileo per affermare la rivoluzione copernicana e abbattere la visione aristotelica del cosmo. Le sue osservazioni lo convinsero che Aristotele si sbagliava e che la ragione stava dalla parte di Copernico!
Purtroppo le sue ricerche scientifiche sconfinavano nel territorio della teologia… ma questo è un altro capitolo della storia, a cui dedicheremo un post a breve.
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. – Marcel Proust
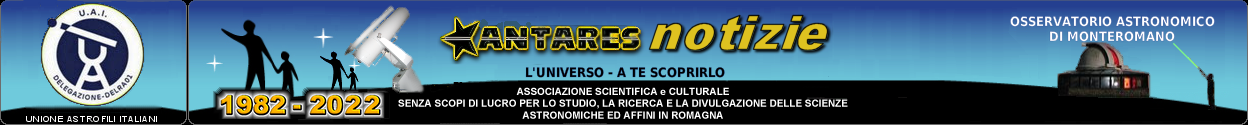






 anni fa Galileo Galilei perfezionò il cannocchiale ma soprattutto ebbe un’idea straordinaria: rivolgerlo verso il Cielo!
anni fa Galileo Galilei perfezionò il cannocchiale ma soprattutto ebbe un’idea straordinaria: rivolgerlo verso il Cielo!


